
Da Napoleone a Giovanni Paolo II, l'astronomo come simbolo conteso
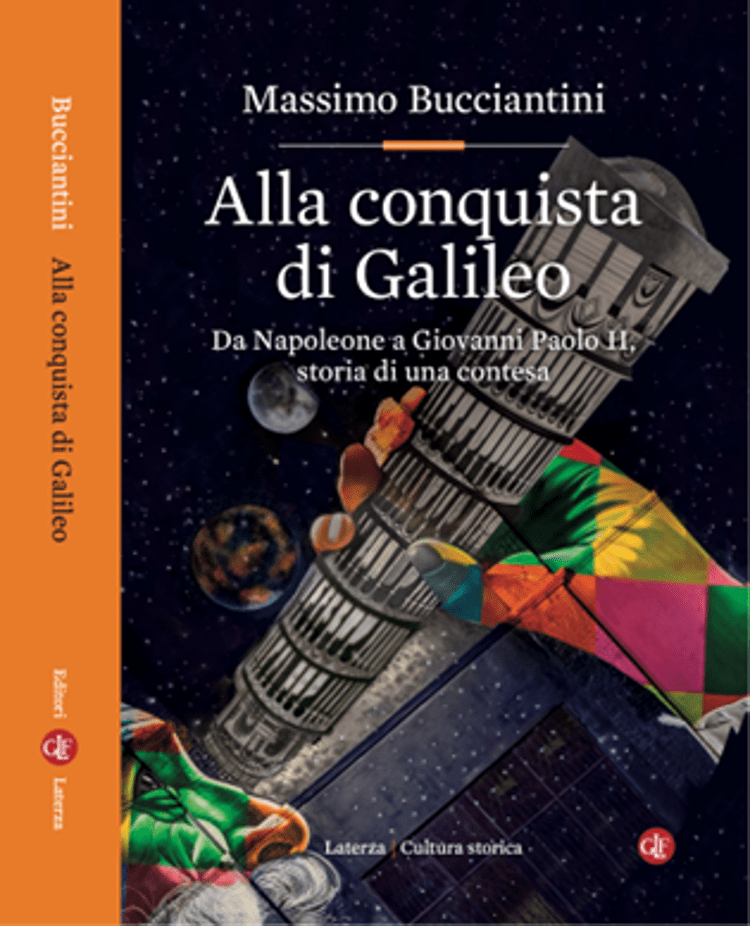
Galileo Galilei non è mai morto davvero. Almeno non nella memoria culturale, politica e ideologica dell'Europa moderna. Il nuovo libro dello storico della scienza Massimo Bucciantini, "Alla conquista di Galileo. Da Napoleone a Giovanni Paolo II, storia di una contesa" (Laterza, in libreria dal 17 ottobre), esplora con rigore e passione il destino postumo di uno degli scienziati più celebri della storia. Ma non è il Galileo fisico e matematico al centro di questo saggio. È piuttosto il Galileo simbolo, archetipo universale della ragione contro l’intolleranza, protagonista involontario di una lunga battaglia culturale che attraversa secoli, nazioni e ideologie.
Basandosi su una vasta mole di fonti, molte delle quali inedite e scovate in archivi e biblioteche di tutta Europa, Bucciantini ci racconta una storia affascinante e per molti versi sorprendente: quella della "conquista del mito di Galileo". Una vera e propria “guerra di appropriazione”, che ha visto protagonisti re, papi, rivoluzionari, scienziati, filosofi, patrioti e intellettuali.
Dalla Francia post-rivoluzionaria all’Italia del Risorgimento, dal fascismo all’epoca della Guerra Fredda, fino alla storica “riabilitazione” voluta da Giovanni Paolo II, Galileo è stato ripetutamente “arruolato” da opposti schieramenti. Prima celebrato come “citoyen français” e simbolo dell’emancipazione razionale contro l’oscurantismo clericale, poi trasformato in martire patriottico dall’Italia risorgimentale, e ancora, esaltato come “genio italico” dal nazionalismo fascista. In un ribaltamento quasi paradossale, nel Novecento il mondo cattolico cercherà di riconsegnarlo alla fede, trasformandolo in figura compatibile con la spiritualità cristiana, se non addirittura in scienziato devoto. Una metamorfosi continua che dimostra quanto il Galileo processato e condannato dall’Inquisizione sia stato – forse più dello scienziato – il vero campo di battaglia simbolico. Perché, si chiede Bucciantini, la Chiesa ha taciuto così a lungo gli atti del processo? E qual è il significato profondo della sua tardiva riabilitazione?
L’opera di Bucciantini si distingue per la capacità di oltrepassare i confini disciplinari: è storia della scienza, certo, ma anche storia politica, culturale e religiosa. A popolare il libro sono personaggi noti – da d’Alembert a Stendhal, da Victor Hugo a Mazzini – ma anche figure poco conosciute ma determinanti, come il patriota Guglielmo Libri, il bibliotecario Silvestro Gherardi o lo storico Pio Paschini. Tutti protagonisti di un lungo e affascinante percorso che ha trasformato Galileo da uomo a mito.
Particolarmente interessante è la parte dedicata al Novecento, quando il “partito cattolico” cerca una vera e propria “riconquista della scienza” dopo la ferita simbolica di Porta Pia. In questo scenario, Galileo diventa il fulcro di una nuova narrazione: quella di uno scienziato compatibile con la fede, recuperabile nella cornice della tradizione cattolica. Ma a quale prezzo?
Massimo Bucciantini è uno dei massimi studiosi italiani di storia della scienza. Professore all’Università di Siena, visiting professor a Parigi e a Zurigo, membro del Comitato scientifico del Museo Galileo di Firenze, è autore di numerosi saggi che hanno fatto scuola, da Galileo e Keplero a Campo dei Fiori, da Esperimento Auschwitz a Pensare l’universo, solo per citarne alcuni. Con questo nuovo libro, aggiunge un ulteriore tassello a una carriera intellettuale all’insegna del rigore, dell’indagine d’archivio e della scrittura divulgativa di alto livello. (di Paolo Martini)